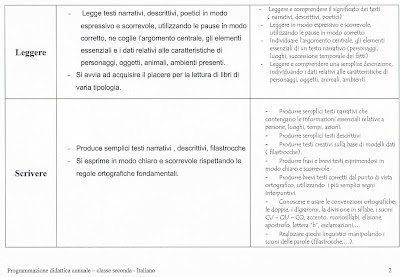Quando chiami all’estero la differenza sta nel trillo del telefono. Non come suona dall’altra parte, ma come lo senti rimbombare dentro la cornetta.
Il tu-tu diventa incerto e gracchiante: corre lontano, saltella e si affanna.
Quando la chiamo e il telefono comincia a fare quel suono strano, riesco a vedere il paesaggio fuori dal finestrino, come fossi a bordo di un treno che procede velocissimo, e quando la voce automatica, alla fine, esclama nella segreteria “Bonjour!”, mi sono alzata dal mio divano e sto passeggiando per le strade di Parigi.
Sono tentata di lasciare un messaggio, ma non li ascoltava dalla segreteria telefonica italiana, sono quasi certa che non lo faccia nemmeno da quella francese.
Elina nasce a Grenoble, nel sud della Francia, all’inizio di febbraio. È il 1986. Nello stesso anno, a luglio, nasco anch’io, in una città di provincia del Nord Italia. Lei tripla cittadinanza, io figlia di due genitori che hanno sempre abitato uno di fronte all’altro, in una stradina piccola, vicino a un bosco, nel mezzo di un paese sull’autostrada per Milano.
Lei studia danza classica nel suo quartiere, il villaggio olimpico, immersa in tanta cultura e in culture diverse. Aperta e sottile. In miniatura. Io cresco odiando ogni sport.
Diventiamo amiche durante il primo anno di liceo: Elina è arrivata in Italia da poco, è l’ora di ginnastica, e lei tenta, con molta pazienza, di farmi imparare la coreografia di Jenny from the Block. Non c’è verso.
Dopo pochi mesi, Elina trascorre i pomeriggi a casa mia a mangiare biscotti – mia madre si premura che non manchi mai nulla per colazione e merenda: c’è un armadio, all’ingresso di casa, ben rifornito. Io mi fermo da lei dopo la scuola, prepariamo cartelloni per le manifestazioni a cui ci accompagna sua madre, insegnante ed ex sessantottina. Cresciamo immaginando l’esistenza di tunnel sotterranei tra le nostre case e quelle dei nostri futuri fidanzati, che di solito non sanno nemmeno come ci chiamiamo.
Il padre di Elina vive a Parigi da tanto tempo, per me da sempre. I miei 16 anni li festeggio sul suo balcone, nel Ventesimo Arrondissement, con i capelli viola, ricci e la felpa della Pickwick sopra la gonna lunga, di jeans. Mi sono appena fatta la permanente e, rientrando in Italia, il mio primo “vero” ragazzo mi dirà che sembro una vecchia di 22 anni.
Io e Elina ci siamo state alle nostre lauree, abbiamo dormito nei nostri letti da universitarie e abbiamo continuato a uscire insieme la sera, fumare troppe sigarette, bere troppi cocktail e mandare troppi sms dopo la mezzanotte, consigliarci musica (più lei), consigliarci libri (più io), parlare di tutto, prendere il sole e presentarci fidanzati. Ridere, soprattutto, in maniera irrefrenabile e tante volte amara, per delle cose su cui con altri non riusciremmo mai a scherzare. Dopo dodici anni continuiamo a provare quella leggera ebbrezza, nello stare insieme, come se la nostra vicinanza potesse realmente escludere le cose brutte. Restituirle al mittente: trovarlo, dovunque esso sia.
È l’8 marzo del 2013, Elina ha deciso di tornare a vivere in Francia e ha scelto di trasferirsi a Parigi. Partiamo per l’ennesima volta insieme. Oltre ad accompagnarla nella primissima fase del trasloco, riscuoterò il mio regalo di laurea: un viaggio in Bretagna con lei. A Saint-Malo, infatti, ha vissuto una persona a me molto cara e Elina mi accompagnerà per la prima volta sulla sua tomba.
Monique l’ho conosciuta in terza media, durante una vacanza studio, prima ancora di incontrare Elina e prima di tornare un sacco di volte in Francia con lei. Una donna bellissima, capace di conquistarti al primo sguardo. Il perché lo capivi dopo: non smetteva mai di sorridere. Non ho più incontrato nessuno capace di sorridere come sorrideva lei. Monique aveva 60 anni e un cancro che si era presentato 12 anni prima del mio arrivo. Nella mia vita è rimasta meno di 10 anni, anche se una parte di lei sta ancora nascosta dietro i miei lati migliori, come una suggeritrice.
Dopo il mio primo soggiorno nella sua casa bretone, sono tornata più volte a Saint-Malo, portando con me anche Elina. Andandocene, lasciavamo bigliettini imbarazzanti sparsi per la casa, destinati ai figli e ai nipoti di Monique: noi, adolescenti imbrattate di trucco, sedotte dallo charme francese.
Merci pour les chatouilles! (grazie per il solletico!)
Monique è venuta a trovarmi in Italia ed è andata a vedere il Duomo, e poi, a un certo punto, il primo gennaio 2008, Monique è morta.
La situazione è precipitata tra Natale e Capodanno: un peggioramento repentino, che lei aveva quasi tenuto nascosto, e la richiesta rivolta a suo marito, Jöel, un uomo mite che le guardava sempre le spalle e scriveva pensieri gentili alla fine delle sue lunghe lettere per me, di chiamarmi. Non sono andata al suo funerale né sulla sua tomba, paralizzata al pensiero del tempo perso che non sarebbe tornato più. Quell’estate ho compiuto 22 anni.
Nel marzo del 2013 io e Elina ci sentiamo molto diverse dalle ragazze senza forma che Monique ha conosciuto, abbracciato e rassicurato. Diciamo che siamo quanto di quelle ragazze è rimasto. Ora ci mettiamo i vestiti delle nostre madri e, in maniera molto moderna, ci guardiamo allo specchio e quello che vediamo ci piace.
A Saint-Malo arriviamo con un passaggio preso tramite Blablacar. Io, Elina, un professore di ginnastica francese e due ragazze bretoni. Da quando ci scaricano dall’auto a quando ripartiamo con il treno passano pochi giorni, meno di una settimana, ma succedono diverse cose: la prima, la più facile da raccontare, ma credo anche la più difficile da immaginare nella sua portata, è che non smette mai di piovere e soffiare un vento tanto forte da non poter opporre nessuna resistenza. Un vento che divelte gli ombrelli sotto cui proviamo a ripararci, che ci rovina gli stivali, ci fa ammalare e sentire costantemente bagnate e gelate. Un vento che passa attraverso le finestre della camera dell’ostello e ci appiccica l’umidità alle ossa.
I primi due giorni mangiamo solo crêpes – per colazione, pranzo e cena – e, a ogni pasto, apriamo sul tavolo la cartina di Saint-Malo e ne studiamo a lungo le strade, seguendo con le dita intirizzite dal freddo i confini della città murata e la lunghezza della spiaggia, come se fossimo sulle tracce di qualcuno. Il problema è che stiamo cercando il cimitero e, chiedendo alla ragazza dell’ostello, che ci ha dato anche la piantina, abbiamo scoperto essercene sette, a Saint-Malo, che di abitanti vivi ne ha cinquantamila. Pochi giorni sembrano di colpo non bastare più: sotto quel cielo cupo, che spiamo da dietro i vetri appannati, diventa chiaro che non ci sarà mai tempo abbastanza per ritrovare Monique.
La mattina del terzo giorno ci sediamo, arrese e sconvolte, a guardare la marea fare il suo giro. Rimaniamo davanti all’oceano per un bel po’, senza parlare, come se fossimo andate fino a lì solo per quello. Come se ci fossimo abituate al vento, al freddo, all’acqua e a quel cielo gigantesco e bassissimo, pieno di nuvole incombenti. Stiamo sedute a guardare la gente che passa sulla spiaggia, liberata dalla bassa marea: nonostante il cattivo tempo, c’è qualche corridore che calpesta il bagnasciuga umido, lasciando impronte irregolari dietro di sé. Scherzo sulla voglia che hanno, con questo tempo, di uscire e fare pure sport; Elina annuisce e mi indica un punto nell’oceano. A prima vista fatico a mettere a fuoco, distinguo solo una massa scura che si muove lentamente: mettendomi gli occhiali, riconosco le sagome di una decina di persone. Uomini e donne, tutti con indosso una muta integrale, nera, immersi nell’acqua fino alla vita, che avanzano vicini. Le braccia lunghe affondano nell’oceano come tentacoli scuri: con le mani si tengono stretti a una corda, che fanno passare tra loro a filo d’acqua. Resto interdetta cercando di capire cosa stiano facendo. Camminano. La temperatura dell’acqua deve metterli a dura prova: vedo le smorfie sulle loro facce esposte all’aria fredda. Anche Elina li segue con lo sguardo: chissà a cosa pensa.
Mi volto verso di lei e le chiedo con slancio se può chiamare per me il numero di casa di Jöel e Monique: temo che l’emozione tradisca il mio francese. Non voglio chiamare Jöel, a essere sincera, per la vergogna di essere sparita tanto a lungo e per la paura di non trovarlo dove lo ricordo. Lei accetta subito, prende il cellulare e fa il numero.
Il telefono squilla a vuoto. Elina mi passa la cornetta appena scatta la segreteria telefonica: io continuo a guardare i camminatori, che si muovono tanto piano da non essere ancora spariti dal mio orizzonte. La voce di Monique è rimasta registrata sul nastro della segreteria.
Ogni giorno a Saint-Malo la marea sale e si ritira. Gli orari sono scritti sul giornale. Monique li leggeva ogni mattina; risentendo la sua voce, impalata davanti all’oceano, penso che le sarebbe piaciuto immaginare lo sguardo assorto dei camminatori mentre scoprono a che ora il mare si farà da parte quel giorno e poi tornerà all’attacco, mangiando panini al latte, in attesa di darsi appuntamento. Lei era una che si interessava alle altre persone.
Qualche giorno dopo, per me e Elina arriva l’ora di prepararci per tornare a Parigi: da lì io partirò per l’Italia. Non siamo andate in nessun cimitero. Abbiamo telefonato diverse volte cercando Jöel e trovando sempre e solo la voce di Monique bloccata nella segreteria. In compenso, siamo tornate sulla spiaggia e abbiamo visto di nuovo la squadra di camminatori: non abbiamo scoperto molto di più su di loro, ma siamo rimaste a guardarli, come se la loro presenza, costante sotto le intemperie, ci facesse compagnia. Rifacciamo le valigie e io scrivo un biglietto, lo avvolgo nel cellophane e Elina si offre di accompagnarmi in quella che è stata la casa di Monique per infilarlo nella buca delle lettere. Abbiamo entrambe voglia di lasciare un segno del nostro passaggio, come facevamo una volta, anche se con meno allegria.
Monique e Jöel vivevano in un quartiere residenziale: la loro casa aveva le persiane turchesi e un giardino ben curato. Dopo anni non è facile riconoscerla tra le altre, soprattutto sotto le raffiche di pioggia, ma è bello, e un po’ sorprendente, ritrovarla al suo posto. Infilo la busta di plastica nella buca mentre Elina tiene l’ombrello con due mani. Guardiamo i vetri bui e ce ne andiamo.
Dopo qualche minuto Elina dice: – Ma se provassimo a richiamare? – . Mi accorgo di capire solo in quel momento cosa significhi avere fiducia in una persona. È qualcosa che ti ritrovi attaccato senza nemmeno accorgertene.
Poi va così: il marito di Monique è appena rientrato, dopo aver trascorso una settimana fuori città. Forse, quando risponde al telefono, nemmeno ha acceso la luce. Probabilmente indossa le scarpe bagnate di pioggia. Jöel non solo ci indica il cimitero giusto, ma ci invita a entrare. La casa è molto cambiata e ora ricorda in ogni dettaglio l’interno di un’imbarcazione, eccezion fatta per le foto, che sono tante, sparse ovunque, sorridenti. Ci offre dello champagne e parliamo di noi, come se davvero fossimo a bordo di una barca, diretti da qualche parte. Per un momento penso di chiedergli se sappia qualcosa a proposito del gruppo di camminatori che io e Elina abbiamo visto dalla spiaggia, ma nel corso della serata me ne dimentico. Ci invita a cena in un ristorante che ama, da cui si vede un promontorio affacciato sull’oceano. Quando usciamo è molto tardi e la collinetta è avvolta dal buio: Jöel ci dice che lassù è stata ricoverata Monique, alla fine. Quello che ci colpisce di lui è quanta voglia di vivere e quanta gratitudine gli siano rimaste in eredità.
Il giorno dopo io e Elina chiamiamo un taxi e dall’ostello ci facciamo portare al cimitero. Ci perdiamo cercando la tomba di Monique: trasciniamo i trolley bagnati e rompiamo altri due ombrelli, uno a testa. Li abbandoniamo in un cestino e continuiamo a salire e scendere per le collinette di quel cimitero in stile anglosassone, fino a quando non troviamo la tomba. Ridiamo, a modo nostro. Le diciamo: – Siamo qui e di solito siamo meglio di così. Siamo venute in due per garantirtelo. – E ridiamo ancora e poi piangiamo anche un po’. Chiamiamo un altro taxi e ci facciamo portare alla stazione: salutiamo Saint-Malo.
Rimango due giorni a Parigi, con Elina, e poi rientro in Italia in treno perché cade così tanta neve che il mio volo viene cancellato. Dopo quel viaggio Elina non tornerà più a vivere in Italia: anche se lo sapevo, lì per lì, seduta a guardare la marea montare e ritirarsi sulla lunga spiaggia bretone, non mi sono chiesta quanto mi sarebbe mancata. Avrò modo di pensarci in seguito, molte volte: tutte le volte che comporrò il suo numero francese sulla tastiera del telefono e poi resterò in attesa, sospesa ad ascoltare quel tu-tu intermittente e ballerino.
A pensarci adesso mi sembra impossibile che ci sia stato un tempo in cui io e Elina vivevamo in due Paesi diversi senza conoscerci. Dei giorni, anzi degli anni, in cui Monique si svegliava e andava fino all’oceano a gettare le sue occhiate benevole ai passanti, e non sapeva niente di me, e la malattia non l’aveva ancora trovata. Eppure. Eppure c’è stato un tempo in cui io e Elina non eravamo nemmeno due vecchie di 22 anni, e questo me lo ricordo bene e ci penso spesso. A volte ripenso anche a quelli che camminavano tenendosi stretti gli uni agli altri con la corda, nell’oceano: mi chiedo se lo facciano ancora e si stiano allenando per qualche competizione. Anche in questo momento, per esempio, mentre fuori dalla mia finestra nevica fitto, mi domando se qualcuno si sia tirato indietro e vada a vederli dalla riva, dove siamo state sedute io e la mia amica per giorni, pensando: “Ma chi me l’ha fatto fare, con il freddo che fa!”.
Quando ho smesso di vivere con i miei genitori, mi capitava le prime volte in cui ci sentivamo al telefono, se ero stata io a chiamare, che loro appendessero e io restassi a sentire il silenzio residuo delle nostre chiacchiere nella cornetta. A immaginare il rumore di casa. Non sono cose che si dicono in giro, queste, ma posso rivelare con una certa allegria che, dopo 10 anni, non lo faccio quasi più.
Irene Roncoroni vive e lavora tra Torino e Milano. Segue l’ufficio stampa della casa editrice digitale Zandegù, legge sempre, nuota ogni volta che è possibile. Su twitter la trovate (da poco) come @NeneRoncoroni.